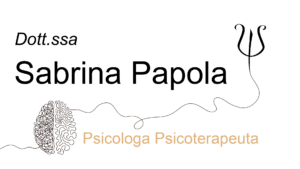Table of Contents
ToggleTi è mai capitato di chiederti: “Perché continuo a fare la stessa cosa anche sapendo che mi fa male?” Oppure: “Cosa c’entra la mia infanzia con il fatto che non riesco a smettere questo comportamento?” La psicoterapia psicodinamica offre una prospettiva profonda e illuminante su questi interrogativi, esplorando come le dinamiche inconsce influenzino i nostri comportamenti più compulsivi.
La psicologia psicodinamica interpreta la dipendenza non come un semplice comportamento disfunzionale, ma come l’espressione inconscia di un disagio profondo, spesso radicato nelle prime esperienze relazionali. In questo articolo esploriamo il legame tra dipendenze e dinamiche interiori, traumi non elaborati, relazioni affettive primarie e processi inconsci che continuano a guidare le nostre scelte anche quando la mente razionale vorrebbe altro.
Se ti stai chiedendo come mai certe “dipendenze” – affettive, comportamentali o da sostanze – sembrano avere una forza più grande della tua volontà, forse è il momento di guardare oltre la superficie del sintomo e comprendere cosa sta davvero succedendo nel tuo mondo interno.
“Ogni sintomo è una parola che il corpo usa quando la mente non riesce a parlare.”
Cos'è l'approccio psicodinamico alle dipendenze?
L’approccio psicodinamico alle dipendenze affonda le sue radici nella rivoluzionaria intuizione di Freud: ciò che facciamo consciamente è solo la punta di un iceberg molto più grande. La maggior parte delle nostre motivazioni, paure e compulsioni opera al di sotto della soglia della coscienza, nell’inconscio.
A differenza degli approcci comportamentali che si concentrano sui sintomi visibili, la psicoterapia psicodinamica va alla ricerca del significato profondo della dipendenza. Non si chiede solo “come smettere”, ma soprattutto “perché è iniziato” e “cosa rappresenta questa dipendenza per il mondo interno della persona”.
Secondo la visione psicodinamica, la dipendenza nasce come tentativo di “auto-cura” di una sofferenza più profonda. La sostanza, il comportamento compulsivo o la relazione tossica diventano una “stampella emotiva” per reggere un peso interno che la persona non riesce a sostenere diversamente.
Questo approccio si distingue dagli altri per tre elementi fondamentali:
- Esplorazione dell’inconscio: I conflitti non risolti e le esperienze traumatiche influenzano i comportamenti attuali senza che ne siamo pienamente consapevoli
- Analisi delle relazioni primarie: Le prime esperienze con le figure di riferimento creano modelli interni che si ripetono nelle dipendenze adulte
- Comprensione dei meccanismi di difesa: La dipendenza spesso maschera strategie inconsce per proteggersi dal dolore
La terapia psicodinamica per le dipendenze non lavora direttamente sul sintomo, ma sulla persona nella sua interezza, esplorando la rete di significati inconsci che sostengono il comportamento compulsivo.

Cos'è l'approccio psicodinamico alle dipendenze?
Dal punto di vista psicodinamico, tutte le dipendenze condividono una matrice psicologica comune, indipendentemente dall’oggetto specifico di dipendenza. Che si tratti di sostanze, comportamenti o relazioni, il meccanismo interno è simile: utilizzare qualcosa di esterno per regolare stati emotivi interni difficili da tollerare.
Dipendenza da sostanze
La dipendenza da sostanze rappresenta il tentativo di modificare chimicamente uno stato emotivo insopportabile. Secondo Jacques Lacan, il tossicomane è colui che “non vuole più sapere niente del desiderio” e cerca nella sostanza un godimento immediato che eviti la complessità delle emozioni umane. La droga diventa un “oggetto transizionale patologico” che promette di colmare il vuoto interno ma finisce per ampliarlo.
Dipendenza affettiva
La dipendenza affettiva si manifesta quando una relazione diventa l’unico modo per sentirsi vivi e avere valore. Non si tratta di amare molto, ma di utilizzare l’altro come regolatore emotivo esterno. Spesso nasce da fallimenti precoci nell’ambiente facilitante: se da bambini non abbiamo ricevuto un “contenimento” emotivo stabile, da adulti cerchiamo disperatamente qualcuno che svolga questa funzione.
Dipendenze comportamentali
Gioco d’azzardo, shopping compulsivo, dipendenza da lavoro o da internet condividono la stessa dinamica: l’azione ripetitiva serve a “spegnere” temporaneamente l’angoscia interna. Secondo Bion, questi comportamenti rappresentano un tentativo disfunzionale di evacuare elementi emotivi “non digeriti” invece di trasformarli in pensiero.
Il denominatore comune
Cosa unisce queste diverse forme di dipendenza? Dal punto di vista psicodinamico, tutte rappresentano:
- Tentativi di auto-regolazione emotiva: Usare qualcosa di esterno per gestire stati interni difficili
- Evitamento della simbolizzazione: Preferire l’azione al pensiero, l’immediato alla riflessione
- Ripetizione di schemi relazionali primari: Ricreare dinamiche infantili irrisolte
- Difesa dall’angoscia di separazione: Paura di stare soli con se stessi e le proprie emozioni
La dipendenza, quindi, non è il problema ma il sintomo di un disagio più profondo che chiede di essere compreso e accolto.
Come nascono le dipendenze: la visione psicodinamica delle cause profonde
Perché alcune persone sviluppano dipendenze e altre no? La psicologia psicodinamica identifica nelle prime esperienze relazionali i fattori determinanti per la vulnerabilità alle dipendenze. Non si tratta di colpevolizzare i genitori, ma di comprendere come certe dinamiche familiari possano creare terreni più fertili per lo sviluppo di comportamenti compulsivi.
Il ruolo dell'attaccamento primario
Secondo Winnicott, ogni bambino ha bisogno di un “ambiente facilitante” che garantisca sicurezza emotiva, contenimento e rispecchiamento adeguato. Quando questo ambiente fallisce – per motivi che possono essere molteplici e non necessariamente volontari – il bambino sviluppa un “falso Sé” per adattarsi alle richieste esterne, mentre il “vero Sé” rimane nascosto e insoddisfatto.
Questa dinamica crea una frattura interna: da un lato c’è la parte che “funziona” socialmente, dall’altro quella autentica ma vulnerabile che resta sepolta. La dipendenza può diventare il tentativo di dare voce a questa parte nascosta o, al contrario, di silenziarne definitivamente le richieste.

Traumi e ferite narcisistiche
Non tutti i traumi sono eclatanti. Spesso sono le piccole ferite ripetute – l’indifferenza emotiva, la critica costante, l’impossibilità di essere visti per quello che si è – a creare le condizioni per future dipendenze. Secondo Kohut, queste “ferite narcisistiche” compromettono lo sviluppo di una sana autostima, rendendo la persona dipendente dall’esterno per sentirsi bene con se stessa.
La letteratura clinica documenta casi in cui persone che non hanno subito abusi eclatanti sviluppano comunque vulnerabilità alle dipendenze a causa di micro-traumi ripetuti: madri cronicamente ansiose che invalidano costantemente le emozioni dei figli, padri emotivamente assenti, famiglie dove i bisogni emotivi dei bambini vengono sistematicamente minimizzati o ignorati.
I meccanismi di difesa primitivi
Di fronte al dolore emotivo precoce, la psiche infantile sviluppa meccanismi di difesa che, pur essendo adattivi nell’immediato, possono diventare problematici nell’età adulta:
- Scissione: Dividere il mondo in “tutto buono” o “tutto cattivo” per evitare l’ambivalenza
- Negazione: Rifiutare la realtà di situazioni dolorose
- Identificazione proiettiva: Proiettare parti di sé sull’esterno per controllarle
- Agire impulsivo (acting-out): Trasformare le emozioni in azioni per evitare di sentirle
La dipendenza diventa quindi un “acting-out” cronico: invece di sentire e pensare il dolore, lo si agisce attraverso il comportamento compulsivo.
Il ruolo dell'infanzia, dei traumi e delle relazioni primarie
La teoria psicoanalitica moderna, arricchita dai contributi delle neuroscienze, evidenzia come le esperienze dei primi anni di vita letteralmente “scolpiscano” il cervello in sviluppo, creando pattern neurali che influenzeranno per sempre il modo di gestire stress, emozioni e relazioni.
Lo sviluppo del sistema di attaccamento
John Bowlby e Mary Ainsworth hanno dimostrato che il tipo di attaccamento sviluppato con i caregiver primari influenza profondamente la capacità di regolazione emotiva. Chi ha sviluppato un attaccamento insicuro – sia esso evitante, ansioso o disorganizzato – ha maggiori probabilità di ricorrere a regolatori esterni (sostanze, comportamenti, relazioni) per gestire stati emotivi intensi.
L’attaccamento disorganizzato, in particolare, è quello più correlato alle dipendenze. Si sviluppa quando il caregiver è al tempo stesso fonte di conforto e di paura, creando nel bambino uno stato di confusione cronica che può portare, da adulto, a cercare sollievo in modi autodistruttivi.
Il trauma cumulativo
Spesso non è un singolo evento traumatico a predisporre alle dipendenze, ma quello che Masud Khan definisce “trauma cumulativo”: una serie di piccole esperienze negative che si accumulano nel tempo. Un genitore cronicamente depresso, conflitti familiari costanti, aspettative irrealistiche o, al contrario, totale disinteresse possono creare un ambiente emotivo tossico che compromette lo sviluppo di solide capacità di autoregolazione.
La teoria dell'auto-medicazione
Edward Khantzian ha proposto la teoria dell’auto-medicazione secondo cui ogni persona sceglie la propria “droga di elezione” in base a specifiche vulnerabilità psicologiche. Chi soffre di ansia potrebbe gravitare verso alcol o benzodiazepine, chi ha difficoltà con l’attenzione verso stimolanti, chi sperimenta vuoto emotivo verso oppiacei. Questa scelta non è casuale ma riflette il tentativo inconscio di “curare” un dolore specifico.
L'eredità transgenerazionale
Le ricerche più recenti evidenziano come i traumi possano essere trasmessi anche attraverso le generazioni. Un genitore che non ha elaborato i propri traumi può inconsapevolmente trasmetterli ai figli, non tanto attraverso i racconti quanto attraverso modalità relazionali disfunzionali, stati emotivi cronici o pattern comunicativi problematici.
Gli studi psicoanalitici documentano come patterns comportamentali disfunzionali si ripetano attraverso le generazioni: genitori con problemi di dipendenza non elaborate trasmettono ai figli non solo predisposizioni genetiche, ma anche modelli relazionali problematici che possono manifestarsi in nuove forme di compulsione o dipendenza.
Meccanismi di difesa e compulsione: quando la mente si protegge
La psicologia psicodinamica dedica particolare attenzione ai meccanismi di difesa, quelle strategie inconsce che la mente utilizza per proteggersi dal dolore. Nelle dipendenze, questi meccanismi assumono caratteristiche specifiche che è importante riconoscere per comprendere la dinamica del disturbo.

La scissione come meccanismo primario
Nella dipendenza, la scissione assume un ruolo centrale. La persona “scinde” la propria esperienza in due parti separate: da un lato c’è il Sé che usa la sostanza o agisce il comportamento compulsivo, dall’altro il Sé che giudica e si vergogna. Questa separazione impedisce l’integrazione dell’esperienza e mantiene la dipendenza.
Come osserva Antonello Correale, il tossicodipendente sviluppa una “doppia vita”: quella “normale” e quella della dipendenza, senza riuscire a integrare le due parti. La sostanza diventa l’unico ponte tra questi due mondi separati, rendendo impossibile l’abbandono senza un lavoro di ricomposizione dell’identità.
La negazione e la minimizzazione
“Non è un problema, posso smettere quando voglio” è la frase tipica di chi utilizza la negazione come difesa principale. Questo meccanismo non è semplice “cattiva fede”, ma una genuina incapacità di registrare la gravità della situazione. La negazione protegge temporaneamente dall’angoscia di riconoscere la perdita di controllo, ma impedisce qualsiasi cambiamento reale.
L'identificazione proiettiva
Nelle dipendenze si osserva spesso un massiccio ricorso all’identificazione proiettiva: gli aspetti inaccettabili di sé vengono proiettati sulla sostanza (“è la droga che mi controlla”) o sull’ambiente (“è colpa dello stress, del lavoro, della famiglia”). Questo meccanismo serve a mantenere un’illusione di controllo ma impedisce di assumersi la responsabilità del cambiamento.
La compulsione alla ripetizione
Freud osservò che tendiamo a ripetere esperienze dolorose nel tentativo inconscio di dominarle. Nelle dipendenze, questo si manifesta attraverso la ricerca compulsiva dell’oggetto di dipendenza proprio nei momenti in cui sarebbe più dannoso. È come se la mente cercasse continuamente di “risolvere” un trauma antico attraverso la ripetizione, senza mai riuscirci.
Il paradosso del controllo
Uno degli aspetti più difficili da comprendere delle dipendenze è il paradosso del controllo: la persona usa la sostanza o il comportamento per sentirsi “in controllo” delle proprie emozioni, ma finisce per perdere il controllo sulla propria vita. Questo paradosso riflette una confusione profonda tra controllo emotivo (che tutti cerchiamo) e controllo onnipotente (che è un’illusione difensiva).
Dipendenza affettiva, da sostanze e comportamentale: l'unità nell'apparente diversità
Sebbene le manifestazioni esteriori possano essere molto diverse, dal punto di vista psicodinamico tutte le forme di dipendenza condividono una struttura interna simile. Comprendere questa unità aiuta a vedere oltre la specificità del sintomo e a cogliere i movimenti profondi della psiche.
La ricerca dell'oggetto primario perduto
Secondo Melanie Klein, ogni dipendenza rappresenta il tentativo di ritrovare l’oggetto primario idealizzato (tipicamente il seno materno come fonte di nutrimento e sicurezza) che è andato perduto nella prima infanzia. La sostanza, la persona di cui si è dipendenti o il comportamento compulsivo assumono le caratteristiche di questo oggetto primario: promettono sicurezza totale, soddisfacimento immediato, fusione beatificante.
Il ciclo della dipendenza come ripetizione del trauma
Tutte le dipendenze seguono un ciclo simile: ricerca compulsiva → soddisfacimento temporaneo → senso di colpa/vergogna → promesse di smettere → accumulo di tensione → ricerca compulsiva. Questo ciclo ripete spesso dinamiche traumatiche dell’infanzia: abbandono, ricongiungimento, delusione, nuovo abbandono.
La letteratura psicodinamica descrive come questo pattern ciclico rappresenti il tentativo inconscio di “riparare” traumi relazionali precoci. Ogni volta che si attiva il ciclo della dipendenza, la persona inconsciamente spera di poter finalmente “controllare” l’esperienza di abbandono o di rifiuto che ha caratterizzato le sue prime relazioni.
L'illusione di controllo attraverso la dipendenza
Paradossalmente, la dipendenza offre un’illusione di controllo: “So che se prendo questa sostanza mi sentirò meglio”, “So che se chiamo questa persona si calmerà la mia angoscia”. È un controllo magico che bypassa la complessità delle relazioni reali e delle emozioni autentiche, ma per questo motivo è anche fragile e destinato a fallire.
La funzione anti-depressiva della dipendenza
Molte dipendenze nascono come tentativo di tenere a bada stati depressivi profondi. L’oggetto della dipendenza funziona come un “antidepressivo comportamentale” che promette di riempire il vuoto interno, dare energia, creare l’illusione di vitalità. Quando l’effetto svanisce, però, la depressione sottostante emerge ancora più intensa, alimentando il ciclo.
Il tempo congelato della dipendenza
Nella dipendenza il tempo assume caratteristiche peculiari: esiste solo il presente del bisogno urgente. Passato e futuro scompaiono, rimane solo l’emergenza dell’ora. Questo “tempo congelato” dal confronto con la storia personale (passato) e con la responsabilità delle scelte (futuro), ma impedisce anche qualsiasi crescita reale.
Come funziona la terapia psicodinamica per le dipendenze?
La psicoterapia psicodinamica per le dipendenze richiede modifiche significative rispetto al setting analitico classico. Come sottolinea Paolo Migone, lavorare con persone dipendenti presenta sfide specifiche che richiedono flessibilità tecnica senza perdere di vista i principi fondamentali dell’approccio.

Le fasi del processo terapeutico
Il lavoro terapeutico si articola generalmente in tre fasi progressive:
- Stabilizzazione e alleanza terapeutica Nella prima fase l’obiettivo non è eliminare la dipendenza ma creare le condizioni per poter lavorare. Questo significa costruire un’alleanza terapeutica solida, fornire contenimento emotivo e aiutare la persona a sviluppare strategie di regolazione emotiva alternative. Spesso il consumo della sostanza può inizialmente aumentare, come osserva Migone, perché il paziente delega inconsciamente al terapeuta la funzione di controllo.
- Esplorazione e elaborazione Una volta stabilizzata la situazione, si può iniziare il vero lavoro di esplorazione delle dinamiche inconsce che sostengono la dipendenza. Si analizzano i sogni, si esplorano i ricordi infantili, si osservano le modalità relazionali che si attivano in terapia attraverso transfert e controtransfert.
- Integrazione e individuazione Nella fase finale si lavora per integrare le parti scisse della personalità e costruire un senso di identità più coeso e autentico. L’obiettivo non è solo smettere di usare la sostanza, ma ritrovare il “soggetto nascosto” sotto la dipendenza, come lo definisce Correale.
Il ruolo centrale della relazione terapeutica
La relazione con il terapeuta diventa lo strumento principale di cura. Il paziente tenderà a riprodurre nella terapia gli stessi pattern relazionali disfunzionali che caratterizzano la sua vita, inclusa la relazione con l’oggetto di dipendenza. Il terapeuta deve essere in grado di contenere questi movimenti senza essere risucchiato nelle dinamiche distruttive.
La funzione di contenimento
Bion ha descritto la funzione di “contenimento” come la capacità di accogliere e trasformare le emozioni crude del paziente (elementi beta) in elementi pensabili (elementi alfa). Nel lavoro con le dipendenze, questa funzione è cruciale: spesso la persona non ha sviluppato sufficienti capacità di autocontenimento e ha bisogno di sperimentare questa funzione nella relazione terapeutica prima di poterla interiorizzare.
Il lavoro con transfert e controtransfert
Il paziente con dipendenze può sviluppare transfert molto intensi e contraddittori: idealizzazione seguita da svalutazione, dipendenza morbosa alternata a fuga, richieste di gratificazione immediate che si trasformano in attacchi quando non vengono soddisfatte. Il terapeuta deve essere preparato a gestire questi movimenti mantenendo una posizione ferma ma non rigida.
Importante: Come psicoterapeuta psicodinamica, il mio interesse per questo tema nasce dalla volontà di approfondire e condividere la ricchezza teorica dell’approccio psicodinamico applicato alla comprensione delle dinamiche di dipendenza. Tuttavia, è fondamentale chiarire che non tratto direttamente le dipendenze da sostanze nella mia pratica clinica. Le dipendenze più severe richiedono spesso un approccio integrato che può includere supporto medico specialistico, programmi di disintossicazione e, in alcuni casi, ricovero in strutture specializzate.
La mia competenza si focalizza sul lavoro psicodinamico con dinamiche relazionali, elaborazione di traumi, disturbi dell’umore e dell’ansia, che possono certamente essere correlati o sottostanti a comportamenti compulsivi, ma richiedono un approccio specifico diverso dal trattamento diretto delle dipendenze.
La relazione terapeutica come esperienza riparativa
Uno degli aspetti più potenti della terapia psicodinamica nel trattamento delle dinamiche di dipendenza è la possibilità di offrire un’esperienza relazionale diversa da quelle che hanno contribuito a creare il problema.
Correggere la relazione primaria
Chi sviluppa dipendenze ha spesso vissuto relazioni primarie caratterizzate da abbandoni emotivi, intrusività, imprevedibilità o traumi. La relazione terapeutica offre l’opportunità di sperimentare una connessione diversa: presente ma non invasiva, stabile ma non possessiva, contenitiva ma non controllante.
La letteratura psicodinamica enfatizza come molte persone con problematiche di dipendenza abbiano bisogno di tempo considerevole per sviluppare fiducia nella relazione terapeutica, avendo spesso vissuto relazioni caratterizzate da imprevedibilità, manipolazione o abbandoni traumatici.
La funzione specchio
Winnicott parla della necessità di essere “rispecchiati” adeguatamente per sviluppare un senso di sé coeso. Molte persone con dipendenze non hanno mai sperimentato questo rispecchiamento autentico: sono stati visti solo per quello che facevano, per i problemi che creavano o per come soddisfacevano i bisogni altrui.
Il terapeuta offre uno “specchio pulito” che riflette la persona nella sua totalità, aiutandola a riconoscere parti di sé che erano rimaste nell’ombra. Questo processo di riconoscimento graduale è spesso più potente di qualsiasi interpretazione tecnica.
Imparare la regolazione emotiva condivisa
Molte persone con dipendenze non hanno mai imparato a regolare le emozioni in modo relazionale. Hanno sviluppato solo strategie solitarie (la sostanza, il comportamento compulsivo) per gestire stati emotivi intensi. La terapia insegna che è possibile condividere emozioni difficili senza essere giudicati o abbandonati, e che la presenza dell’altro può effettivamente alleviare la sofferenza senza eliminarla artificialmente.

È possibile superare una dipendenza solo con la psicoterapia?
La risposta a questa domanda dipende da molteplici fattori: il tipo di dipendenza, la sua gravità, le risorse della persona, il contesto di vita e la presenza di altre problematiche associate.
Quando la psicoterapia può essere sufficiente
La psicoterapia psicodinamica può essere l’intervento principale in caso di:
- Dipendenze comportamentali senza compromissione fisica grave (gioco, shopping, dipendenza affettiva)
- Dipendenze “leggere” da sostanze in persone con buon funzionamento sociale e lavorativo
Situazioni dove la dipendenza è chiaramente collegata a traumi o dinamiche psicologiche specifiche che possono essere elaborate
Quando è necessario un approccio integrato
Per dipendenze più gravi, specialmente da sostanze, è spesso necessario un lavoro di équipe che può includere:
- Supporto medico-psichiatrico per la gestione degli aspetti neurobiologici
- Programmi di disintossicazione per l’interruzione dell’uso di sostanze
- Comunità terapeutiche per chi necessita di un ambiente protetto
- Gruppi di auto-aiuto per il supporto tra pari
- Interventi familiari per modificare dinamiche relazionali disfunzionali
L'importanza dei tempi
La psicoterapia psicodinamica lavora sui tempi lunghi, mentre alcune dipendenze richiedono interventi immediati per preservare la salute fisica o la vita stessa della persona. In questi casi, la psicoterapia può iniziare dopo o durante altri interventi più urgenti, quando la persona ha raggiunto una stabilità minima.
Il valore aggiunto della comprensione psicodinamica
Anche quando sono necessari altri interventi, la comprensione psicodinamica delle dinamiche di dipendenza arricchisce qualsiasi approccio terapeutico. Capire il significato inconscio della dipendenza, le sue radici relazionali e i meccanismi difensivi coinvolti aiuta a prevenire ricadute e a costruire motivazioni più solide per il cambiamento.
Come sottolineano le ricerche, gli effetti della terapia psicodinamica tendono a mantenersi e amplificarsi nel tempo, offrendo benefici che vanno oltre la semplice cessazione del comportamento problematico: maggiore autoconoscenza, migliori capacità relazionali, più solide strategie di regolazione emotiva.
Quando iniziare un percorso terapeutico per comprendere le proprie compulsioni
Riconoscere di avere un problema è il primo passo verso la guarigione, ma spesso è anche il più difficile. La natura stessa della dipendenza include meccanismi di negazione che rendono difficile l’auto-osservazione obiettiva.
Segnali che meritano attenzione
Alcuni segnali possono indicare che è il momento di cercare aiuto professionale:
- Perdita di controllo: Continuare un comportamento nonostante le conseguenze negative evidenti
- Centralità nella vita quotidiana: Quando la sostanza o il comportamento diventano il fulcro intorno a cui ruota tutto il resto
- Isolamento sociale: Preferire la dipendenza alle relazioni autentiche
- Compromissione del funzionamento: Difficoltà lavorative, relazionali o di salute correlate
- Cicli di promesse e ricadute: Tentare ripetutamente di smettere senza successo
- Sensazione di “doppia vita”: Vivere una scissione tra la parte “normale” e quella della dipendenza
Il momento giusto non esiste
Molte persone aspettano di “toccare il fondo” prima di chiedere aiuto, ma questo non è necessario né auspicabile. Il momento giusto per iniziare una terapia è quando si inizia a percepire che qualcosa non va, anche se non si è ancora pronti a cambiare tutto immediatamente.
La ricerca psicodinamica suggerisce che iniziare un percorso terapeutico quando si hanno ancora sufficienti risorse psicologiche ed esterne permette un lavoro più efficace e profondo rispetto all’attesa di una crisi maggiore.
Il primo colloquio come porta d'ingresso
Il primo colloquio con uno psicoterapeuta psicodinamico non è un impegno vincolante, ma un’opportunità per esplorare. Durante questo incontro è possibile:
- Condividere i propri dubbi e preoccupazioni senza giudizio
- Comprendere se l’approccio psicodinamico può essere utile
- Iniziare a intravedere connessioni tra sintomi attuali e storia personale
- Sentire se c’è sintonia con il terapeuta
Superare la resistenza iniziale
È normale provare ambivalenza verso l’idea di iniziare una terapia. La parte dipendente della personalità “sa” che la terapia potrebbe mettere in discussione il suo equilibrio, per quanto disfunzionale. Questa resistenza non è un difetto ma un meccanismo comprensibile che può essere esplorato in terapia.
Se riconosci qualcosa di te in queste righe, forse è il momento giusto per iniziare. Non è necessario avere tutto chiaro, è sufficiente aver percepito che qualcosa nella propria vita meriterebbe di essere compreso più profondamente.
Verso una maggiore consapevolezza di sé
La psicoterapia psicodinamica non promette soluzioni rapide o formule magiche per eliminare le dipendenze, ma offre qualcosa di più duraturo: la possibilità di comprendere profondamente se stessi e trasformare la sofferenza in saggezza.
Il viaggio verso la libertà dalle compulsioni passa attraverso la comprensione. Comprendere perché continuiamo a ripetere pattern distruttivi, cosa rappresentano per il nostro mondo interno, quale bisogno autentico stanno cercando di soddisfare in modo disfunzionale.
Le dipendenze, vista dall’ottica psicodinamica, non sono nemici da combattere ma sintomi da decifrare, messaggi dell’inconscio che chiedono di essere ascoltati e tradotti in un linguaggio più consapevole.
Questo processo di comprensione richiede coraggio: il coraggio di guardare oltre la superficie dei comportamenti, di esplorare zone dolorose della propria storia, di mettere in discussione certezze consolidate. Ma offre in cambio la possibilità di una libertà autentica, non basata sul controllo esterno ma sulla comprensione profonda di sé.
Il primo passo verso questa comprensione può iniziare esplorando le dinamiche relazionali e i traumi che spesso sono alla base di comportamenti compulsivi.
👉 Contattami per un primo colloquio se senti che le dinamiche relazionali, l’elaborazione di traumi o la comprensione profonda di pattern comportamentali ripetitivi risuonano con la tua esperienza.
Qual è la differenza tra dipendenza e abitudine secondo l'approccio psicodinamico?
Dal punto di vista psicodinamico, un’abitudine è un comportamento ripetitivo che mantiene una funzione adattiva e può essere modificato consciamente. La dipendenza, invece, implica una compulsione inconscia: la persona continua il comportamento nonostante le conseguenze negative, perché questo serve a regolare stati emotivi profondi difficili da tollerare. La dipendenza ha sempre una funzione difensiva inconscia che l’abitudine normale non possiede.
Quanto dura un percorso psicodinamico per comprendere dinamiche di dipendenza?
La durata varia in base alla complessità del caso, alla storia personale e agli obiettivi. La comprensione delle dinamiche inconsce che sostengono comportamenti compulsivi è un processo che richiede tempo – generalmente si parla di percorsi medio-lunghi (1-3 anni) per trasformazioni profonde. I primi insight possono emergere già nei primi mesi, ma l’integrazione stabile richiede elaborazione più approfondita.
Che ruolo ha l'inconscio nei comportamenti compulsivi secondo l'approccio psicodinamico?
L’approccio psicodinamico considera l’inconscio come il “motore” principale dei comportamenti compulsivi. Esperienze traumatiche, conflitti irrisolti e bisogni affettivi non soddisfatti continuano a operare sotto la soglia della coscienza, spingendo verso comportamenti ripetitivi che promettono sollievo temporaneo. Il lavoro terapeutico mira a rendere conscio questo materiale inconscio, permettendo scelte più libere e consapevoli.
La psicoterapia psicodinamica può sostituire altri trattamenti per le dipendenze?
No, per dipendenze severe, specialmente da sostanze, la psicoterapia psicodinamica da sola non è sufficiente. È necessario un approccio integrato che può includere disintossicazione medica, supporto psichiatrico, comunità terapeutiche e gruppi di auto-aiuto. Tuttavia, la comprensione psicodinamica delle cause profonde arricchisce qualsiasi trattamento e aiuta a prevenire ricadute.
Perché continuo ad attrarre relazioni tossiche o situazioni autodistruttive?
Dal punto di vista psicodinamico, tendiamo a ripetere pattern relazionali appresi nell’infanzia, anche quando sono dolorosi. Questo accade attraverso la “coazione a ripetere”: inconsciamente ricreiamo situazioni familiari nel tentativo di “riparare” traumi antichi. La terapia psicodinamica aiuta a riconoscere questi pattern e a sviluppare modalità relazionali più sane.